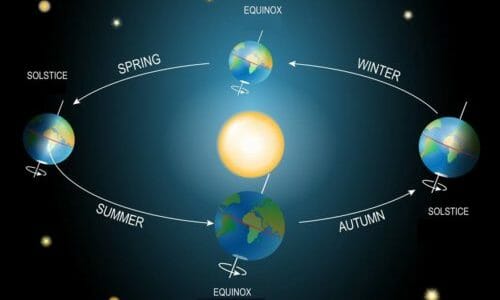Come combattere l’inquinamento acustico? I rimedi a un problema spesso sottovalutato.
Ecco come fare la lotta al rumore, uno dei tipi di inquinamento più subdoli
I suoi effetti negativi sulla salute umana e sulla qualità della vita sono ormai noti: l’inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi (e sottovalutati) problemi ambientali, a causa dell’elevato e diffuso impatto sulla popolazione.

Contenuti
- Inquinamento acustico: i disturbi più comuni
- Danni fisici dell’inquinamento acustico
- Danni psicologici dell’inquinamento acustico
- Le tipologie di inquinamento acustico
- Come si misura l’inquinamento acustico
- Inquinamento acustico: la normativa
- Oltre la normativa: come fare la lotta al rumore
- Inquinamento acustico: soluzioni contro il rumore di traffico
- Inquinamento acustico: norme per le abitazioni
- Come proteggersi dall’inquinamento acustico
- Approfondimenti tematici
Il fastidio provocato dai rumori è un’esperienza quotidiana per chi vive nel caos dei centri urbani. Parla chiaro l’Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale i frastuoni derivati dal traffico cittadino rappresentano il più rilevante problema ambientale europeo dopo l’inquinamento atmosferico. La salute di circa 30 milioni di abitanti del Vecchio Continente è attualmente messa a rischio dall’esposizione a livelli eccessivi di decibel.
Per evitare guai seri, l’OMS raccomanda il rispetto delle soglie di esposizione, fissate a 65 decibel durante il giorno e a 55 nel corso della notte.
Inquinamento acustico: i disturbi più comuni
Molte ricerche specialistiche hanno infatti dimostrato come l’incidenza di disturbi del sonno, infarti, ictus, ipertensione e malattie cardiovascolari, sia più diffusa tra la popolazione che vive nella congestione di città particolarmente rumorose, rispetto a quella meno sottoposta ai rumori.
L’esposizione a questi volumi altissimi incide sulla salute umana, pregiudicando lo stato di benessere fisico, mentale e sociale di ognuno di noi. Gli effetti nocivi, che consistono in danni fisici, disturbi nelle attività e fastidi generici, dipendono dalle caratteristiche fisiche del rumore prodotto, dalle condizioni di esposizione e dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta.
Danni fisici dell’inquinamento acustico
Si distinguono in:
- Uditivi. Si registrano due tipi di danno: quello acuto, che segue a una stimolazione acustica particolarmente intensa (ad esempio un’esplosione) e si realizza in tempo brevissimo, e quello cronico, dalla più lenta evoluzione, successiva a un’esposizione protratta nel tempo (parecchie ore al dì per un periodo di almeno 10 giorni). La diminuzione dell’udito causata dal rumore, definita ipoacusia di tipo neuro-sensoriale, può esser quantificabile attraverso esami audiometrici, è irreversibile e si manifesta con vari sintomi, quali fatica uditiva, insensibilità, fastidio accompagnato da ronzio e vertigini.
- Extra-uditivi. Al di fuori del nostro orecchio il rumore provoca guai seri anche al resto del nostro organismo. Gli effetti sono i più vari: dall’aumento della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria ai disturbi all’apparato gastrointestinale (dispepsia, maggiore motilità e secrezione gastrica); dalle alterazioni al sistema nervoso centrale all’iperattività di ipofisi, tiroide e surrene a livello del sistema endocrino, fino alle modificazioni apportate al sistema immunitario.
Danni psicologici dell’inquinamento acustico
L’esposizione al rumore è fonte di stress, poiché provoca variazioni accertabili della pressione sanguigna, del ritmo cardiaco, della vasocostrizione e della secrezione endocrina.
In materia di disturbi alle attività, il rumore incide negativamente sullo studio e su tutti i lavori di tipo intellettuale, oltre che sulla comunicazione verbale e sul sonno. In linea di principio, negli ambienti abitativi il rumore non dovrebbe eccedere 40-45 dB(A), una situazione resa spesso impossibile dal caos del traffico cittadino anche tenendo le finestre chiuse, mentre per garantire il giusto riposo il livello sonoro massimo dovrebbe attestarsi al di sotto dei 45 dB (A), altrimenti possono verificarsi difficoltà nell’addormentarsi e alterazioni quantitative e qualitative nel ciclo del sonno.
Infine, come effetto meno specifico, ma pur sempre grave, dobbiamo considerare il fastidio generico, definito come ‘un sentimento di scontentezza riferito al rumore che l’individuo sa o crede possa agire su di lui in modo negativo». In parole povere, si tratta di cosa provate quando vi sentite disturbati o impediti nel comunicare normalmente, nello svolgere le vostre attività o durante il momento del riposo’.
Le tipologie di inquinamento acustico
Il rumore, che si configura come una sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa o intollerabile, può essere di vari tipi (continuo o discontinuo, stazionario o fluttuante, costante o casuale, impulsivo) e provenire da varie sorgenti (traffico stradale, ferroviario e aereo; attività artigianali, commerciali e industriali; fenomeni meteorologici; elettrodomestici o altre apparecchiature presenti in casa).
- Traffico veicolare rappresenta la principale forma di disagio per i cittadini, poiché coinvolge gran parte della popolazione. Le segnalazioni acustiche, l’attrito degli pneumatici sulla strada o delle ruote dei tram sulle rotaie, i rombi dei motori, lo scarico dei gas combusti, le mutue azioni dinamiche tra carrozzeria e aria circostante rappresentano purtroppo la nostra colonna sonora quotidiana…oggetto delle più varie imprecazioni!
- Traffico ferroviario, che disturba un numero inferiore di persone e produce un rumore di debole impulsività e dalla traccia acustica stabile, provocato dal motore e dall’attrito ruota-rotaia.
- Traffico aereo sta invece acquisendo una crescente rilevanza in ambito territoriale, anche se per fortuna interessa solamente le aree in prossimità degli aeroporti e i cosiddetti “corridoi di sorvolo”. In questo caso, i fastidi al nostro udito sono provocati dai motori dei velivoli e dalle fragorose fasi di atterraggio e decollo.
- Attività industriali e artigianali, il rumore connesso agli impianti è prodotto da una sorgente puntiforme e origina un’area di esposizione circolare. L’intensità dipende dalla potenza sonora della sorgente, mentre la traccia acustica risulta piuttosto stabile nel tempo.
- Attività commerciali (avrete sicuramente presenti gli alti volumi di officine, bar, pub, discoteche ecc.),
- Fenomeni meteorologici (ciascuno di voi sarà sobbalzato più di una volta di fronte al fragore dei tuoni di un temporale)
- La vita domestica (in questo caso entrano in campo televisori, stereo e radio tenuti a volumi alti, così come i rumori eccessivi prodotti dagli strumenti musicali o da lavoro o da altri elettrodomestici quali l’aspirapolvere, l’asciugacapelli o la lavatrice.
Come si misura l’inquinamento acustico
L’inquinamento acustico si misura mediante i fonometri, che rilevano il livello di pressione sonora alle varie frequenze, ricavando un valore che prende in considerazione la diversa sensibilità dell’orecchio umano a quest’ultime.
Uno degli indicatori per la descrizione di questo problema ambientale è dato dalla popolazione esposta al rumore, un parametro che l’OMS ha inserito tra gli “European Community Health Indicators”.
In pratica, rientra in questa categoria la fascia di popolazione costretta a sorbirsi livelli continui equivalenti di rumore superiori a 65 decibel nel periodo diurno, e a 55 decibel in quello notturno.

Inquinamento acustico: la normativa
La principale norma nazionale di riferimento sull’inquinamento acustico, la legge quadro n. 447/95, definisce questo fenomeno come «l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con la funzionalità degli ambienti stessi».
Passiamo ora ad analizzare i principali strumenti normativi atti a combattere questo fenomeno.
- La direttiva comunitaria 49/2002/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale ha cercato di uniformare le definizioni e i criteri di valutazione dell’inquinamento acustico. Questa norma è stata recepita a livello nazionale col decreto legislativo n. 194/2005 che ha adottato il ricorso a specifici indicatori acustici e precise metodologie di calcolo, prevedendo anche la valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acustiche, la maggiore attenzione all’informazione della popolazione, nonché l’identificazione e la conservazione di aree di quiete. Nel decreto sono inoltre indicate le competenze e procedure per l’elaborazione e l’adozione dei piani d’azioni per evitare o ridurre il rumore ambientale.
- La legge quadro n. 447/95 sull’inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali per la difesa dal rumore dell’ambiente esterno e di quello abitativo, attribuendo diverse funzioni e compiti a Stato, Regioni, Province e Comuni.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (14/11/1997), che determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità delle sorgenti sonore, definendo le classi di destinazione d’uso del territorio. I valori limite di attenzione sono quelli che una volta superati impongono l’adozione di un piano di risanamento comunale, mentre per valori limite di qualità si intendono i limiti di zona che devono esser conseguiti nel breve, medio e lungo periodo, mediante il ricorso alle tecnologie e ai metodi di risanamento disponibili.
A livello locale, gli strumenti fondamentali che la legge individua per una sensibile politica di riduzione dell’inquinamento acustico sono essenzialmente due:
- la zonizzazione acustica, che prevede la distinzione del territorio comunale in sei classi in base ai livelli di rumore, permettendo la limitazione o prevenzione del deterioramento del territorio così come la tutela delle zone particolarmente sensibili
- il piano di risanamento acustico, che scatta quando non vengono rispettati i limiti di zona e comprende provvedimenti amministrativi, normativi e regolamentari, oltre a interventi concreti di tipo tecnico (ad esempio installazioni di barriere, interventi su edifici ecc.)
Oltre la normativa: come fare la lotta al rumore
Al di là delle norme di buona convivenza civile e rispetto degli altri, sono numerose le azioni che possono essere intraprese per la lotta al rumore. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ne segnala alcune:
- l’abbattimento del rumore alla fonte
- l’uso di macchine, attrezzature e strumenti con basse emissioni rumorose
- la manutenzione periodica e l’eventuale sostituzione di macchine, apparecchiature e strumenti
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva (insonorizzazione degli ambienti) e individuale (otoprotettori)
- la sorveglianza sanitaria degli esposti
- la vigilanza sul rispetto della normativa vigente
Inquinamento acustico: soluzioni contro il rumore di traffico
Per quanto riguarda il traffico stradale, la limitazione passa per l’incentivazione all’utilizzo dei veicoli elettrici e allo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblici e privati, la riduzione dei limiti di velocità, l’introduzione di alcuni accorgimenti tecnici sulle automobili (marmitte elettroniche, pneumatici silenziosi ecc.), il finanziamento delle attività di ricerca per lo sviluppo di veicoli a basse emissioni inquinanti, e l’applicazione di asfalti fonoassorbenti (quelli porosi riducono gli effetti del ristagno d’acqua, mantengono un’eccellente aderenza e riducono notevolmente l’emissione di rumori).
Molti sono gli interventi possibili nell’ambito della progettazione architettonica. I cortili alberati e le barriere di siepi sono per esempio dei fonoassorbenti naturali, che oltre a ridurre i rumori migliorano la nostra qualità di vita, regalandoci un po’ di verde e di pace. Vi sono inoltre specifiche modalità di orientamento, isolamento e costruzione degli edifici che possono contribuire a rendere più silenziose le nostre città. Il design può quindi fare la differenza!
Certamente, va segnalato che resta molto da fare per garantire l’effettiva applicazione delle norme. La famosa legge quadro n. 477/95 ha reso obbligatoria la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di classificazione acustica, così come la redazione della relazione biennale sullo stato acustico, per i Comuni con oltre 50mila abitanti. Ebbene, stando ai dati forniti dall’Ispra, nel 2013 il piano di classificazione acustica è stato approvato solo in 46 delle 73 città individuate nel rapporto Osservatorio Rumore (63%), mentre la relazione biennale sullo stato acustico è stata compilata solamente dal 21% dei Comuni interessati.
Al di là dell’applicazione della legislazione vigente, servono quindi sforzi ulteriori per arginare questa minaccia sempre più pericolosa, che non risparmia neppure il nostro Paese. Lo dimostrano i dati forniti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che nel 2013 ha rilevato un superamento dei limiti normativi nel 46% dei controlli effettuati sulle varie sorgenti di rumore. Le maggiori criticità sono state riscontrate nelle attività di servizio e/o commerciali e nelle infrastrutture stradali, entrambe con un 52% di violazioni.
Inquinamento acustico: norme per le abitazioni
Nelle case, specie nei condomini cittadini, la convivenza forzata di tante persone dà luogo a numerosi rumori domestici che possono risultare intollerabili e che spesso portano a numerosi litigi.
Tuttavia le sorgenti del rumore possono trovarsi anche all’esterno dell’edificio (traffico, mezzi di trasporto, impianti industriali, lavori stradali, costruzioni).
Un buon isolamento acustico interno permette di difendersi dai rumori molesti ma va comunque ricordato che l’ordinamento giuridico nazionale garantisce la salvaguardia delle persone mediante l’applicazione dell’articolo 844 del Codice Civile che impone anche dei limiti di rumorosità. Questa norma si posiziona in un quadro normativo introdotto nel Belpaese una ventina d’anni fa, con l’obiettivo di indicare precisi criteri per la valutazione delle immissioni sonore ritenute disturbanti per le persone e talvolta dannose per la salute.
Il concetto chiave, nei confronti dell’esposizione a sorgenti rumorose, è rappresentato dalla soglia della “normale tollerabilità”.
Si definisce inquinamento acustico “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”
Non solo, la legge n. 447/1995 art. 2 fornisce una definizione più precisa rispetto al passato di inquinamento acustico: “…l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”.
Come proteggersi dall’inquinamento acustico
La tutela dell’ambiente dagli effetti nocivi derivanti dall’esposizione al rumore può essere realizzata attraverso le diverse azioni. In sostanza, per difenderci dall’inquinamento acustico, provvediamo in primis ad isolare acusticamente la nostra abitazione.
Si possono eseguire diversi interventi:
- Isolare un edificio dall’esterno: si può foderare internamente il tetto e le pareti con dei pannelli fonoassorbenti di materiale naturale come sughero, canapa o fibre di kenaf pressate, che isolano anche termicamente, per cui il vantaggio è duplice.
- Infissi: devono essere installati a regola d’arte ed essere a chiusura ermetica. L’impiego di vetrocamere con intercapedine riempita da un gas inerte e l’uso di vetri stratificati migliora ancora di più le prestazioni.

- Pavimento: può essere isolato mediante l’applicazione tra massetto e rivestimento di un tappeto in materiale fonoassorbente sempre in canapa o kenaf. Serve ad attutire le vibrazioni sonore prodotte dai passi e da chi salta e corre. Anche gli scarichi possono creare rumori molesti, specialmente nelle ore notturne, tanto è vero che in alcuni condomini (soprattutto in Svizzera) ne è vietato l’uso di notte. Rivestimenti in materiale fonoassorbente sono disponibili per ricoprire le tubature.
- Zonizzazione acustica. A livello di sorgenti di rumore ambientali esterne il comune deve invece prevedere degli specifici limiti di accettabilità di rumore e realizzare dei piani di zonizzazione acustica con eventuale risanamento acustico – qualora i livelli di rumorosità ambientale superino i suddetti valori limite -fino a ricondurre i livelli di rumorosità ambientale a determinati valori ottimali, i cosiddetti valori di qualità. Da questo punto di vista la normativa individua 6 classi acustiche e fissa dei limiti assoluti in termini di livelli di immissione, emissione e qualità, in funzione del periodo di riferimento diurno (06:00 – 22.00) e notturno (22:00 – 06:00).
Si consideri però che la legge in tema di inquinamento acustico prevede un ‘limite differenziale’ tra interno ed esterno delle abitazioni. Un evento rumoroso è considerato non accettabile solo se la differenza tra il “livello del rumore ambientale ed il livello sonoro residuo” è superiore a 5 dB (giorno) e 3 dB (notte).
Come si può intuire, le emissioni sonore da e verso un edificio rappresenta un elemento di fondamentale importanza. Noi cittadini e le autorità competenti, dobbiamo vigilare che il tutto si svolga nel rispetto delle norme e che la qualità della vita non sia compromessa dall’eccessivo inquinamento acustico.
Approfondimenti tematici
Ti suggeriamo di leggere anche:
- L’inquinamento olfattivo
- Inquinamento luminoso: che cos’è e come combatterlo
- Labirintite: disturbo dell’orecchio che provoca vertigini e nausea
- Acufene: cos’è e come trattarlo naturalmente
- Motori: più inquinante il diesel della benzina?
- Due app per misurare inquinamento atmosferico e acustico