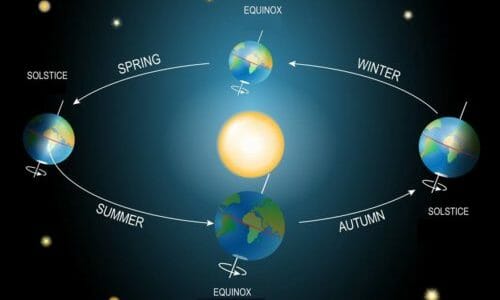Disastri ambientali: i peggiori nella storia dell’uomo
Ripercorriamo i maggiori disastri ambientali della storia moderna: un modo per fare una doverosa riflessione anche sui veri costi del modello economico e sociale basato sugli idrocarburi che ha dominato l’ultimo secolo.

Contenuti
- I peggiori disastri ambientali nella storia umana
- Disastri ambientali: i disastri petroliferi
- Disastri ambientali: il caso della Russia e dei paesi ex-sovietici
- Disastri ambientali: dal 2100 faranno sempre più vittime
- Disastri ambientali: dalla prevenzione alla limitazione dei danni
- Approfondimenti consigliati
Disastri ambientali: pagine nere della storia umana, troppo rapidamente rimosse di volta in volta. Un dibattito che si riaccende tristemente solo nel momento in cui si verifica una nuova emergenza.
Ma è un dibattito tutt’altro che scolastico, come vedremo. E’ un dibattito denso di implicazioni. Se per risalto mediatico, infatti, il disastro della Deepwater Horizon è secondo solo all’incidente nucleare di Chernobyl, con ogni probabilità non si tratta del secondo disastro ambientale per gravità nella storia. Basti pensare al disastro di Bhopal in India nel 1984, che causò qualcosa come 15 o 20mila vittime. E forse nemmeno della perdita di petrolio più grave.
Una considerazione, questa, che non vuole affatto sminuire la portata del disastro della marea nera nel Golfo del Messico. Al contrario, vuole richiamare l’attenzione su altre catastrofi ecologiche causate dall’uomo. Catastrofi magari trascurate dai media per il fatto di accadere in paesi del terzo mondo, lontani dai centri di potere e dai focus dei media.
I peggiori disastri ambientali nella storia umana
Impossibile fare una classifica senza tenere conto del costo in termini di vite umane. Per questa ragione, molti ritengono la tragedia di Bhopal del dicembre 1984 la peggiore del genere nella storia umana.
- Bhopal, Madhya Pradesh, India. Fu causato dalla fuoriuscita di 40 tonnellate di una sostanza altamente tossica (isocianato di metile) da uno stabilimento della Union Carbide India Limited. La fuoriuscita venne causata da da gravi carenze delle misure di sicurezza dell’impianto. Inizialmente vennero stimati 4.000 morti, avvolti da una nebbia tossica nei pressi dello stabilimento. Nei giorni successivi, venne rilevato come circa altre 50.000 persone furono contaminate dalla fuoriuscita. Molti subirono danni permanenti ed invalidanti (insufficienza renale, cecità). Altri (probabilmente 15mila persone) persero la vita nei mesi ed anni successivi a causa della contaminazione.
- Chernobyl: uno dei più gravi incidenti nucleari nella storia. Le conseguenze sulla salute umana e sul numero di persone morte per conseguenze legate all’incidente ancora oggi fa discutere. A più di 30 anni dall’incidente, non esiste una cifra ufficiale di decessi accertati. Che si tratti di poche migliaia o di diverse decine di migliaia di persone non lo sapremo mai con certezza. Quel che è certo è che, ancora oggi, un’area di quasi tremila chilometri quadrati attorno alla centrale è inabitabile e off-limits per uomo.

Disastri ambientali: i disastri petroliferi
Tra i disastri ambientali a cavallo tra il ventesimo ed il ventunesimo secolo, una costante è quella della presenza dell’oro nero. La sete di petrolio è stata la causa prima di un numero elevato di disastri ambientali di conseguenze enormi.
E’ per esempio il caso della perdita di petrolio pressoché ininterrotta in corso dagli anni sessanta nel delta del Niger. Dati di Foreign Policy, seppur approssimativi a causa delle scarse rilevazioni effettuate, parlano di 546 milioni di galloni di petrolio dispersi dall’inizio delle estrazioni, equivalenti a un disastro dell’entità dell’Exxon Valdez, la perdita di petrolio più grave nella storia americana fino al 2010 prima della Deepwater Horizon, ogni anno.
Un disastro senza fine, dove da un lato ladri e sabotatori di petrolio causano perdite continuamente e dall’altro le stesse compagnie petrolifere – per non incorrere in costi troppo alti – lavorano in condizioni di sicurezza inadeguate, perpetuando un circolo vizioso.
Ma è solo la Nigeria purtroppo ad essere stata colpita da una catastrofe petrolifera. Ecco un breve elenco di disastri petroliferi che hanno caratterizzato la nostra storia recente:
- 1978: il 16 Marzo 1978 la petroliera di bandiera liberiana Amoco Cadiz, un supertanker da 234.000 tonnellate, affittato dalla compagnia statunitense Amoco, filiale della Standard Oil, andò alla deriva al largo delle coste bretoni, proprio davanti al borgo di Portsall, rilasciando in mare circa 230.000 tonnellate di greggio.
- 1988: il 6 Luglio 1988, un’esplosione nella piattaforma petrolifera Piper Alpha della Occidental Petroleum Ltd. e della Texaco nel Mare del Nord, a circa 190 km dalle coste scozzesi, causò la morte di 167 lavoratori nella piattaforma e perdite di greggio non stimabili per entità.
- 1989: il 24 marzo 1989 la petroliera americana Exxon Valdez si incagliò in una scogliera dello stretto di Prince William, un’insenatura del golfo di Alaska, disperdendo in mare 40,9 milioni di litri di greggio. Probabilmente per il fatto di essere accaduto negli Stati Uniti, è il disastro petrolifero che ha ricevuto più attenzione da parte dei media fino a questa primavera, ma secondo alcuni esperti non è nemmeno nella top ten dei disastri petroliferi della storia. Eppure l’incidente della Exxon Valdez contaminò 1,300 miglia di coste in Alaska. Le conseguenze della perdita a quasi 30 anni di distanza sono ancora visibili, con petrolio presente in diversi tratti nonostante anni di operazioni di bonifica e alterazioni permanenti all’ecosistema.
- 1991: in occasione della prima Guerra del Golfo, l’esercito iracheno diede fuoco a qualcosa come 650 pozzi di petrolio in Kuwait per prevenire un’azione militare via terra della coalizione capitanata dagli americani, con circa un milione di tonnellate di greggio disperse nell’ambiente e pozzi in fiamme per diverse settimane.
- Last, but not least, il caso della marea nera del Golfo del Messico. Il 20 aprile 2010, per cause mai totalmente precisate, avvenne un’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon al largo delle Louisiana. L’equivalente di oltre 3 milioni di barili di petrolio fuoriuscì dai pozzi in profondità nel Golfo del Messico. Una vicenda chiusa dal punto giudiziario con una maxi-condanna per BP.
Disastri ambientali: il caso della Russia e dei paesi ex-sovietici
Si tratta di un caso di conseguenze da industrializzazione forzata senza precedenti storici. Con un passaggio all’agricoltura intensiva e con opere di irrigazione enormi, senza alcuna considerazione di natura ambientale. Per colmare il gap con le altri grandi potenze – in quella che era la grande sfida, anche militare e spaziale, con gli Stati Uniti e tutto l’Occidente – nel secolo scorso l’Unione Sovietica letteralmente “sottomise” le sue terre e le loro risorse naturali agli obiettivi che si era imposta con i piani di sviluppo quinquennali. Il tutto per oltre 50 anni, tra il primo dopoguerra e gli anni ’80.
Peccato che le vie adottate per raggiungere gli obiettivi che le permettessero di brillare come super-potenza nello scacchiere mondiale fossero in molti casi soluzioni che non valutavano gli effetti collaterali, soprattutto ambientali.
E così grandi appezzamenti di terreni, fiumi e laghi importanti sono stati gravemente danneggiati dall’agricoltura intensiva di tipo collettivista. Il suolo si è eroso e salinizzato, l’aria in molti distretti industriali è irrespirabile.
Senza considerare il problema mai risolto delle acque reflue e dei rifiuti radioattivi.
Risultato? Un ambiente violentato e ridotto a pezzi, quello che si può osservare tra le pianure e i distretti metropolitani di quella che oggi è tornata a chamarsi Russia e nelle ex-repubbliche che un tempo erano sotto il controllo di Mosca.
Eppure, per evitare il disastro, qualche azione a suo tempo le autorità avrebbero potuto intraprenderla. Già intorno al 1930, un gruppo di scienziati lanciò l’allarme sulle metodologie di lavoro impiegate nei campi e nelle fabbriche. Agli stessi anni datano anche attendibili rapporti redatti da professionisti ingaggiati dal regime proprio per analizzare rischi ed effetti negativi sull’ambiente delle politiche di sviluppo economico.
Tutto pressoché inutile, dal momento che politici e scienziati credevano nel principio della “auto-purificazione”, secondo cui l’ambiente e la biosfera sarebbero stati in grado di adattarsi a vari tipi di inquinamento senza subire gravi danni, se si contenevano entro un certo range le concentrazioni massime di inquinanti. Evidentemente il limite è stato superato, e di molto.
Con l’avvento della glasnost nel 1980, nuove organizzazioni non governative hanno iniziato a coinvolgere lo Stato in un dibattito sulle questioni ambientali. Nel 1988 venne poi istituito un Comitato di Stato per la tutela dell’ambiente naturale ma la delicata fase politica che negli anni successivi che portò al crollo dei regimi comunisti mise la questione e gli interventi nel dimenticatoio. Nel 2000, il Comitato venne addirittura sciolto.
CONOSCI QUESTO POSTO? Derweze, la porta dell’inferno: il fuoco che brucia da 40 anni in Turkmenistan
Dieci anni di transizione hanno prodotto miseri risultati. La questione è passata tra le mani del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), che ha stilato un elenco di problemi che necessitano di urgente attenzione.
Quali sono questi problemi? La gestione incontrollata dei rifiuti pericolosi, il trattamento delle acque reflue inaffidabile, il deterioramento della qualità dell’aria negli agglomerati urbani e industriali. Ma non solo. Anche la contaminazione e i danni al suolo da pesticidi e sovrasfruttamento dei terreni sono gli effetti collterali spesso irreversibili che Russia e suoi ex-paesi satelliti stanno scontando.
All’opera di sensibilizzazione non sono però seguite azioni concrete ed anche le agenzie governative competenti in materia ambientale possono oggi ben poco. I finanziamenti sono insufficienti, la percezione comune è che questi territori enormi siano risorse infinite e intanto la situazione per l’ecosistema, la salute degli abitanti e degli animali continua a peggiorare.
SPECIALE: Il Lago d’Aral, storia di un disastro ambientale… pianificato dall’uomo!

Francamente oggi sembra difficile trovare una luce in fondo al tunnel per salvaguardare il territorio di questi enormi Paesi.
Disastri ambientali: dal 2100 faranno sempre più vittime
Sta iniziando una nuova epoca caratterizzata da disastri ambientali sempre più grandi e frequenti? Sembrerebbe di sì. Ormai non ci sono più dubbi. Se l’uomo continuerà a maltrattare l’ambiente modificando profondamente i suoi equilibri, i prossimi decenni saranno costellati di disastri ambientali e calamità naturali sempre più ingenti.
E non è tutto: stando alla recente relazione presentata dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale, le perdite globali connesse ai cambiamenti climatici e cataclismi (terremoti, tsunami, alluvioni, ondate di calore) potrebbero triplicare arrivando a fare danni per 185 miliardi di dollari entro il 2100.
Già nel 2011 l’ONU ha calcolato che le perdite economiche causate dai disastri ambientali hanno segnato il record negativo di 286 miliardi di euro, con 302 eventi classificati come ‘catastrofici’ che sono costati la vita ad oltre 29.500 persone in tutto il Mondo. E come se non bastasse, altre 260 milioni di persone hanno subito direttamente gli effetti di tali eventi.
Tra tutti, il terremoto e il conseguente tsunami verificatosi in Giappone nel 2011 rappresentano la perdita più ingente, sia in termini umani (15.703 morti accertati e 4.647 dispersi) che economici (210 miliardi di dollari).
Disastri ambientali: dalla prevenzione alla limitazione dei danni
Per la fine di questo secolo, dunque, il quadro non è più incoraggiante anche se gli esperti sottolineano che basterebbe adottare poche e semplici misure preventive per limitare i danni. Il rapporto esorta, in particolare, a rivedere le condizioni di locazione di molte abitazioni in India dove la manutenzione è praticamente inesistente e le case si sgretolano alla prima pioggia violenta.
Incoraggia anche la conservazione di infrastrutture chiave come gli ospedali e scuole. Questi luoghi possono in alcuni casi rappresentare il rifugio più sicuro per gli sfollati. Ma soprattutto pone l’attenzione sulla salvaguardia dei cosiddetti ‘tamponi ambientali’, come le foreste di mangrovie, che possono prevenire l’erosione del terreno e neutralizzare l’effetto di maremoti e inondazioni.
Il futuro dell’umanità è appeso al solito, esile, filo e in effetti si comincia a parlare più di come ‘limitare i danni’ che di come ‘scongiurarli’. Il punto è che di questo passo, un giorno non troppo lontano, la conta delle vittime potrebbe diventare veramente infinita.
Approfondimenti consigliati
Forse ti potrebbe interessare anche:
- Danno ambientale: che cos’è, spiegato in parole semplici
- Plastica nei mari, presto una situazione che sarà fuori controllo
- Deforestazione: che cos’è quali sono le sue conseguenze e perché accade, spiegato bene
- Quali sono i luoghi più inquinati al mondo
- Inquinamento luminoso: che cos’è e come combatterlo
- Piogge acide: perché si verificano e che conseguenze dannose hanno
- Inquinamento acustico: che cos’è?