Additivi alimentari, si o no? Dipende da quali e dalla quantità: ecco come orientarsi
Quali sono e a cosa servono
Gli additivi alimentari sono sostanze impiegate nell’industria alimentare durante la preparazione, lo stoccaggio e la commercializzazione degli alimenti destinati al consumo umano. Il loro utilizzo è finalizzato principalmente alla conservanti, edulcoranti e coloranti alimentari.
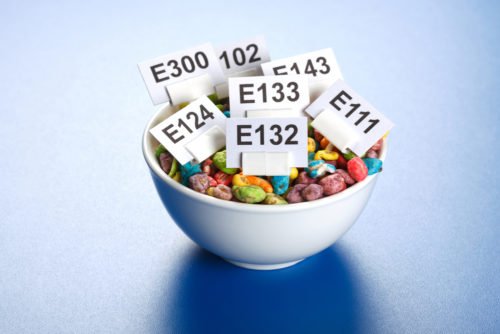
Contenuti
- Additivi alimentari: cosa sono
- Gli additivi alimentari fanno male?
- Additivi alimentari pericolosi
- Classificazione
- Additivi alimentari naturali
- Additivi alimentati artificiali
- Gli additivi alimentari e Ministero della Salute
- Elenco degli additivi
- Coloranti
- Coloranti da evitare
- Conservanti
- Conservanti da evitare
- Antiossidanti
- Antiossidanti da evitare
- Correttori di acidità
- Correttori di acidità da evitare
- Addensanti, gelificanti, emulsionanti, stabilizzanti
- Sostanze da evitare
- Sali e agenti lievitanti
- Sali e lievitanti da evitare
- Esaltatori di sapidità (da evitare)
- Dolcificanti nocivi
- Altre informazioni
Nei Paesi appartenenti all’UE, queste sostanze sono identificate nell’etichetta alimentare con una sigla preceduta dalla lettera E. La presenza di additivi alimentari, infatti, deve essere indicata per legge tra gli ingredienti degli alimenti. Le etichette, inoltre, devono riportare sia la funzione dell’additivo impiegato che la sostanza specifica utilizzata.
Gli additivi più più comunemente impiegati dall’industria del cibo sono antiossidanti, coloranti alimentari, emulsionanti, stabilizzanti, gelificanti, addensanti, conservanti e dolcificanti.
Ma vediamo nel dettaglio cosa sono, quali è bene evitare e come distinguere gli additivi alimentari naturali da quelli artificiali o potenzialmente tossici.
Additivi alimentari: cosa sono
Anche se sono quasi irrilevanti dal punto di vista quantitativo, gli additivi alimentari possono essere decisivi per valutare l’aspetto salutistico e qualitativo di un prodotto. Citando testualmente la definizione riportata nella Direttiva del Consiglio 89/107/CEE, sappiamo che è considerato additivo alimentare:
“Qualsiasi sostanza che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi un componente di tali alimenti”.
In altre parole, si tratta di sostanze “addizionate” alla superficie o alla massa dei cibi per migliorare, esaltare o conferire determinate caratteristiche del prodotto finito. I coloranti, per esempio, per imprimere una colorazione uniforme e più “appetibile”; gli addensanti per migliorarne la consistenza; gli antiossidanti per preservarne la freschezza e così via.
Gli additivi alimentari fanno male?
La tossicità degli additivi alimentari, specie quelli di sintesi chimica, è uno degli argomenti più discussi e controversi in ambito medico e alimentare. Alla domanda sull’effettiva pericolosità di alcuni additivi, la risposta è ‘dipende’. Nella maggior parte dei casi, infatti, la quantità è il fattore determinante.
L’Unione Europea ha stabilito una dose giornaliera massima per ogni additivo alimentare. In caso di abuso, gli effetti collaterali più comuni sono emicrania, allergie, patologie intestinali, iperattività. Un altro moltiplicatore di pericolosità di queste sostanze è rappresentato dall’effetto combinato e dall’interazione con alcuni alimenti.
Un esempio lampante sono le nitrosammine, sostanze cancerogene formate dalla combinazione di nitrati e ammine già presenti negli alimenti.

Additivi alimentari pericolosi
Associazioni, ambientalisti ed esperti di tutto il Mondo hanno stilato un elenco delle sostanze additive più sospette, anche se non riconosciute ufficialmente come “pericolose”. Eccole di seguito:
- Nitriti e nitrati: legandosi con le ammine durante le lavorazioni delle carni o nell’intestino umano, possono dare le nitrosammine, sostanze giudicate cancerogene dall’International Agency for the Reasearch on Cancer (IARC).
- Bromato di potassio (pane e cracker): è classificato dallo IARC come probabile cancerogeno.
- Propyl Parabene: come conservante utilizzato nei prodotti da forno, è un contaminante ubiquitario.
- Idrossianisolo butilato o BHA: probabile cancerogeno. L’Unione Europea lo considera un distruttore endocrino pericoloso. Viene utilizzato nelle patatine fritte e in altri cibi grassi come conservante ed esaltatore di sapidità.
- Idrossitoluene butilato o BHT: secondo l’EFSA è causa di tumori del fegato e del polmone negli animali, ed è un probabile distruttore endocrino.
- Propil gallato: conservante per salse, è un presunto distruttore endocrino e un cancerogeno.
- Teobromina: componente naturale del cioccolato usato come additivo nel pane, nei cereali e nelle bibite per sportivi. Possibili effetti negativi sullo sviluppo e sulla riproduzione.
- Coloranti artificiali: il 4-metil-imidazolo o il 4-MEI, vietato in Europa perchè potenzialmente cancerogeno.
- Diacetile: alternativa del burro nei popcorn per microonde, è associato a gravi malattie respiratorie.
- Fosfati: aumentano il rischio cardiovascolare.
- Alluminio: stabilizzante associato a disturbi nello sviluppo e a malattie neurodegenerative. Tende ad accumularsi in tessuti e ossa, ed è neurotossico.
Altri additivi ritenuti sospetti o da evitare, sono:
- aspartame
- saccarina
- oli vegetali bromurati
- glutammato monosodico
- sciroppo di fruttosio
- parabeni
- anidride solforosa
- butilidrossianisolo E20( BHA )
- solfito di sodio
- olio vegetale parzialmente idrogenato
- azodicarbonammide
Classificazione
Gli additivi sono classificati in base alla loro funzione. Essi possono essere divisi in 3 grandi gruppi:
- additivi che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti;
- che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti;
- additivi tecnologici (facilitano la lavorazione degli alimenti).
Come abbiamo visto, la presenza di additivi nei prodotti alimentari è indicata sulle etichette da alcune sigle e cifre. Il codice che serve ad identificarli di solito è la lettera E seguita da un numero di identificazione. Esistono diverse modalità di classificazione, ma al più semplice è la seguente:
- E100-E199 (coloranti)
- E200-E299 (conservanti)
- E300-E399 (antiossidanti e regolatori di acidità)
- E400-E499 (addensanti, stabilizzanti e emulsionanti)
- E500-E599 (regolatori di acidità e antiagglomeranti)
- E600-E699 (esaltatori di sapidità)
- E950-E969 per i dolcificanti
- E900-E909 per le cere
- E910-E919 per le glasse
- E920-E929 per gli agenti ausiliari
- E930-E949 per i gas di confezionamento
- E990-E999 per gli schiumogeni
- E1100-E1599 per tutte le altre sostanze.
Additivi alimentari naturali
Oltre alla funzione specifica per la quale vengono impiegati, gli additivi alimentari possono essere suddivisi in base alla loro origine. Di fatto, si definiscono “naturali” gli additivi derivanti da estratti vegetali/animali/minerali o anche di sintesi chimica di sostanze presenti in natura.
Un altro gruppo sono gli additivi di sintesi chimica che in natura non sono presenti e che sono creati in laboratorio con sintesi artificiale dell’uomo.
Esempi
Tra gli edulcoranti o additivi aromatici naturali più utilizzati per migliorare il sapore dei prodotti alimentari,troviamo:
- zucchero di canna (edulcorante)
- miele (edulcorante)
- vanillina (aroma natural-identico)
- acido ascorbico
- clorofilla
- anidride carbonica
- lecitina di soia
- betacarotene
Spesso capita di avere a che fare con la dicitura ‘aromi naturali di‘ In questo caso siamo di fronte ad una sostanza costituita per il 95% da una sostanza naturale (per esempio l’aroma di fragola o di limone).
Additivi alimentati artificiali
Gli additivi alimentari ottenuti per sintesi chimica a partire da sostanze non presenti in natura, sono detti “artificiali“. Tra gli additivi alimentari sintetici molto discussi c’è l’aspartame, dolcificante usato nei prodotti definiti “light” o dietetici e in una nota bevanda. Senza dimenticare anche il glutammato di sodio, un esaltatore di sapidità presente in tantissimi prodotti industriali lavorati un tempo molto chiacchierato.
Additivi senza glutine
Prima di essere impiegati, tutti gli additivi alimentari devono essere testati e autorizzati dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Di norma, queste sostanze sono prive di glutine, dunque adatte anche al consumo da parte di soggetti celiaci.
Nel caso gli additivi impiegati contengano glutine, essi devono essere espressamente indicati come previsto dal regolamento sull’etichettatura dei prodotti contenenti allergeni.
Gli additivi alimentari e Ministero della Salute
In Italia l’uso degli additivi è una pratica disciplinata dal Ministero della Sanità attraverso il DM 31.3.1965 che è allineata alle direttive dettate dalla Comunità Europea.
In Europa il controllo sulla sicurezza degli additivi alimentari è gestito dallo SCF (Scientific Committee for Food), ovvero il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana della Commissione Europea. Questo organismo collabora a livello internazionale con il JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives), con la FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura) e con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Elenco degli additivi
Di seguito, potete leggere l’elenco completo degli additivi alimentati più utilizzati e divisi per tipologia, con indicazioni sui tipi da evitare perché potenzialmente pericolosi o dubbi (Fonte: Albanesi.it):
Coloranti
- E100 Curcumina
- E101 Riboflavina (vitamina B2)
- E120 Cocciniglia (acido carminico)
- E140 Clorofilla
- E141 Clorofilla
- E150 Caramello E150a-b-c-d
- E160 Beta-carotene (provitamina A) e derivati
- E161 Luteina (E161b) Cantaxantina (E161g)
- E162 Rosso barbabietola, betaina
- E163 Antociani
- E160d Licopene
Coloranti da evitare
- E102 Tatrazina
- E123 Color amaranto
- E127 Eritrosina
- E104 Colore giallo
- E128 Rosso 2G
- E131 Blu patentato V
Conservanti
- E200 Acido sorbico
- E202 Sorbato di potassio
- E203 Sorbato di calcio
- E260 Acido acetico
- E261 Acetato di potassio
- E262 Acetati di sodio
- E263 Acetato di calcio
- E270 Acido lattico
- E290 Anidride carbonica
Conservanti da evitare
- E210 Acido benzoico
- E211 Benzoato di sodio
- E212 Benzoato di potassio
- E213 Benzoato di calcio
- E214 p-idrossibenzuato d’etile
- E215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio
- E216 p-idrossibenzoato di propile
- E217 Propil-p-idrossibenzoato di sodio
- E218 p-idrossibenzoato di metile
- E219 Metil-p-idrossibenzoato di sodio
- E220 Anidride solforosa
- E221 Solfito di sodio
- E222 Sodio bisolfito
- E223 Metabisolfito di sodio
- E224 Metabisolfito di potassio
- E225 Metabisolfito di calcio
- E226 Solfito di calcio
- E227 Calcio bisolfito
- E228 Potassio solfito acido
- E230 Bifenile, difenile
- E231 Ortofenilfenolo
- E232 Ortofenilfenolo sodico
- E233 Tiabendazolo
- E235 Natamicina
- E239 Esametilentetramina
- E242 Dimetildicarbonato
- E249 Nitrito di potassio
- E250 Nitrito di sodio
- E251 Nitrato di sodio
- E252 Nitrato di potassio
Antiossidanti
- E300 Acido ascorbico
- E301 Ascorbato di sodio
- E302 Ascorbato di calcio
- E304 Palmitato di ascorbile
- E306 Estratto ricco in tocoferolo
- E307 Alfatocoferolo
- E308 Gammatocoferolo
- E309 Deltatocoferolo
- E322 Lecitina di soia
Antiossidanti da evitare
- E310 Gallato di propile
- E311 Gallato di d’ottile
- E312 Gallato di dodecile
- E315 Acido eritorbico
- E316 Eritorbato di sodio
- E320 Butilidrossianisolo e butilidrossitoluolo
- E321 (nei chewing-gum superando 1 pacchetto al giorno)
Correttori di acidità
- E325 Lattato di sodio
- E326 Lattato di potassio
- E327 Lattato di calcio
- E330 Acido citrico
- E331 Citrati di sodio
- E332 Citrati di potassio
- E333 Citrati di calcio
- E334 Acido tartarico
- E335 Tartrato di sodio
- E336 Tartrato di potassio
- E337 Tartrati di sodio e potassio
- E375 Niacina
Correttori di acidità da evitare
- E338 Acido fosforico (penalizza l’assimilazione di calcio)
- E339 Fosfato di sodio
- E340 Fosfato di potassio
- E341 Fosfato di calcio
- E350 Malati di sodio
- E351 Malati di potassio
- E352 Malati di calcio
- E353 Acido metatartarico
- E354 Tartrato di calcio
- E355 Acido adipico
- E356 Adipato di sodio
- E357 Adipato di potassio
- E363 Acido succinico
- E380 Citrato triammonico
- E385 EDTA
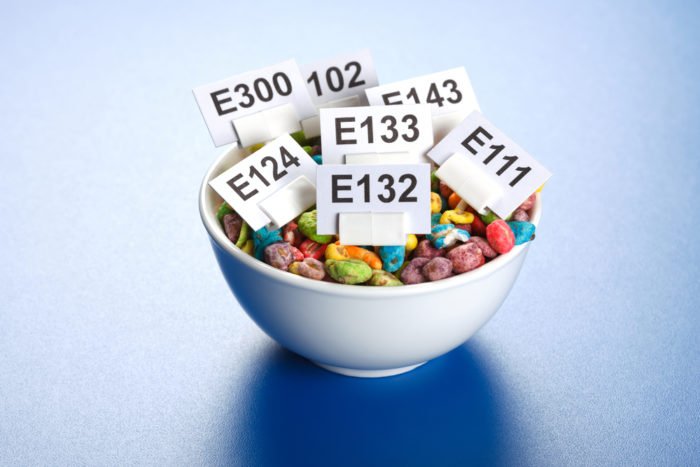
Addensanti, gelificanti, emulsionanti, stabilizzanti
- E400 Acido alginico
- E401 Alginato di sodio
- E402 Alginato di potassio
- E403 Alginato d’ammonio
- E404 Alginato di calcio
- E405 Alginato di 1.2 propandiolo
- E406 Agar-agar
- E407 Carragenina
- E410 Farina di semi di carrube
- E412 Gomma di guar
- E413 Gomma adragante
- E414 Gomma d’acacia (gomma arabica)
- E415 Gomma di xanthan
- E416 Gomma di karaya
- E417 Gomma di tara
- E418 Gomma di gellano
- E420 Sorbitolo
- E421 Mannitolo
- E422 Glicerolo
- E431 Stearato di poliossietilene
- E432 Monolaurato di poliossietilensorbitano
- E433 Monooleato di poliossietilensorbitano
- E434 Monopalmitato di poliossietilensorbitano
- E435 Monostearato di poliossietilensorbitano
- E436 Tristearato di poliossietilensorbitano
- E440 Pectine
- E442 Fosfati di d’ammonio
- E444 Saccarosio di isobutirrato acetato
- E445 Esteri della glicerina della resina del legno
- E460 Cellulosa
- E461 Metilcellulosa
- E463 Idrossi-propil-cellulosa
- E464 Idrossi-propil-meticellulosa
- E465 Etilmetilcellulosa
- E466 Carbossimetilcellulosa
- E470a Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi
- E470b Sali di magnesio degli acidi grassi
- E471 Mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E472a Esteri acetici di mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E472b Esteri lattici di mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E472c Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E472d Esteri tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E472e Esteri mono-e diacetitartarici di mono-e diglicerididegli acidi grassi
- E472f Esteri misti acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi
- E474 Sucrogliceridi
- E475 Esteri poliglicerici degli acidi grassi
- E476 Poliricinoleato di poliglicerolo
- E477 Esteri dell’1.2 propandiolo degli acidi grassi
- E479b Prodotto di reazione dell’olio di soia ossidato termicamente con mono-e digliceridi degli acidi grassi
- E481 Stearoil-2 lattilato di sodio
- E482 Stearoil-2 lattilato di calcio
- E483 Tartrato di stearile
- E491 Monostearato di sorbitano
- E492 Triestearato di sorbitano
- E493 Monolaurato di sorbitano
- E494 Monooleato di sorbitano
- E495 Monopalmitato di sorbitano
Sostanze da evitare
- E450 Difosfato disodico (solo come lievitante)
- E451 Trifosfati (solo come lievitante)
- E452 Polifosfati
Sali e agenti lievitanti
- E500 Carbonato di potassio
- E503 Carbonati d’ammonio
- E504 Carbonati di magnesio
- E508 Cloruro di potassio
- E509 Cloruro di calcio
- E511 Cloruro di magnesio
- E570 Acido stearico e derivati
- E571
- E572
Sali e lievitanti da evitare
- E512 Cloruro stannoso
- E513 Acido solforico
- E514 Solfati di sodio
- E515 Solfati di potassio
- E516 Solfato di calcio
- E520 Solfato d’alluminio
- E521 Solfato di alluminio e sodio
- E522 Solfato di alluminio e potassio
- E523 Solfato di alluminio e ammonio
- E524 Idrossido di sodio
- E525 Idrossido di potassio
- E526 Idrossido di calcio
- E527 Idrossido d’ammonio
- E528 Idrossido di magnesio
- E529 Ossido di calcio
- E530 Ossido di magnesio
- E535 Ferrocianuro di sodio
- E536 Ferrocianuro di potassio
- E538 Ferrocianuro di calcio
- E541 Fosfato acido di sodio e alluminio
- E551 Biossido di silicio
- E552 Silicato di calcio
- E553a Silicato di magnesio
- E553b Talco
- E554 Silicato di sodio e alluminio
- E555 Silicato di potassio e alluminio
- E556 Silicato di calcio e alluminio
- E559 Silicato di alluminio (caolino)
Esaltatori di sapidità (da evitare)
- E620 Acido glutammico
- E621 Glutammato monosodico
- E622 Glutammato monopostassico
- E623 Diglutammato di calcio
- E624 Glutammato monoammonico
- E625 Diglutammato di magnesio
- E626 Acido guanilico
- E627 Guanilato disodico
- E628 Guanilato dipotassico
- E629 Guanilato di calcio
- E630 Acido inosinico
- E631 Inosinato disodico
- E632 Inosinato dipotassico
- E633 Inosinato di calcio
- E634 5′-ribonucleotidi di calcio
- E635 5′-ribonucleotidi di sodio
- E640 Glicina e suo sale di sodio
Dolcificanti nocivi
- E952 Ciclamato e i suoi derivati
Altre informazioni
Approfondisci il tema degli agenti che sono aggiunti agli alimenti:
- stabilizzanti
- conservanti
- addensanti
- emulsionanti
- solfiti
- etichetta alimentare
- agar-agar
- xantano
- pectina
- lecitina di soia
- gomma arabica
- carragenina
- solfiti
- xilitolo
- eritrolo
- colla di pesce
- farina di carrube





Grazie per l’aiuto , ora so che devo dire addio al 90% della mia lista spese e sostituirla con alimenti piu sani.